Per chi si ferma a pensare il mondo di oggi è un caos: fast fashion, prodotti con una longevità minima, sprechi, sovraconsumo e un sistema che non aiuta l’individuo a ridurre il suo impatto sul mondo.
Proprio per questi motivi oggi parlare di Sharing Economy non è solo doveroso, ma fondamentale. Speriamo che questi non rimangano discorsi “vuoti”, ma che possano influenzare l’opinione di uno, per poi diventare la richiesta di molti e indirizzare così il business e la cooperazione internazionale verso obiettivi comuni.
In un mondo sovraffollato, pieno di richieste di beni e servizi e dove si iper-produce massimizzare l’utilizzo di beni e servizi, portare una transizione controllata verso una capitalismo improntato al green è il solo modo di mantenere intatto il nostro sistema di vita, che è destinato velocemente al collasso, migliorare l’impatto sul pianeta e produrre nuove opportunità di lavoro.
Scopriamo allora qualcosa di più sulla sharing economy, su come funziona, quali sono i suoi vantaggi e i suoi rischi.
Cos’è la sharing economy e come funziona

La sharing economy o economia della condivisione è un nuovo modello economico-sociale che si basa sulla possibilità di individui, nazioni e organizzazioni di scambiare o mettere a disposizione beni e servizi (anche tramite il digitale).
Questo paradigma non convenzionale nasce dalla concreta conoscenza di un dato fondamentale: molte risorse e persino molte competenze professionali, restano spesso inutilizzate per lunghissimi periodi. In questo caso una economia basata sulla condivisione permette di valorizzare queste risorse sottoutilizzate come:
- Competenze digitali;
- Case;
- Auto;
- Strumenti di lavoro.
E molto altro. In questo caso le risorse, di qualsiasi tipo, possono essere messe in condivisione da chi le possiede e ciò permette a chi ne ha bisogno di accedervi senza doverle acquistare in modo definitivo.
Questo crea un circolo virtuoso dove non si sprecano le risorse e dove tutti possono averne accesso, senza doverne per forza pagare il costo. Ciò permette a tutti, anche ai meno fortunati di avere la possibilità di accedere a risorse importanti.
Il funzionamento della sharing economy ha come principio base l’intermediazione digitale, sono le piattaforme digitali e le app che mettono in contatto diretto domanda e offerta. Le piattaforme di questo tipo svolgono un ruolo cruciale, rendono i processi smart e veloci dove sono le piattaforme stesse a generare fiducia e a fornire gli strumenti di tutela per questo scambio.
Pensando in termini molto più ampi: nell’economia della condivisione il concetto di proprietà viene traslato in quello di accesso temporaneo poiché, ciò che conta non è possedere il bene o la risorsa, ma poterla utilizzare quando se ne ha bisogno.
Questo approccio si può riflettere in qualsiasi ambito della vita, con la tecnologia che rende le nuove forme di collaborazione e scambio personalizzate e flessibili rispetto ai modelli tradizionali. In questo modo il sistema si ridefinisce, in favore non solo di tutti, ma anche del pianeta: non servirà così avere troppe cose o impattare sul pianeta in modo così evidente: più condivisione ovvero meno prodotti o servizi inutilizzati, prodotti o portati all’obsolescenza e più ottimizzazione delle risorse.
Modelli principali: peer-to-peer, on-demand, access economy
La sharing economy si articola principalmente in tre diversi modelli ovvero:
- Peer-to-peer;
- On-demand;
- Access economy.
Sono modelli diversi tra di loro, capaci di intrepretare l’equazione dell’economia della condivisione, a modo loro e di influenzare così il comportamento degli utenti, le dinamiche sociale e anche l’ambiente.
Per quanto riguarda il modello peer-to-peer della sharing economy troviamo una struttura decentralizzata sulla quale gli individui possono interagire per scambiare beni o servizi senza intermediari.
Si tratta in questo caso di un sistema egualitario dove domanda e offerta si incontrano e dove è possibile trovare prezzi di molto inferiori rispetto ai mercati tradizionali e dove per molti utenti è possibile avere nuove opportunità di guadagno su prodotti o servizi inutilizzati.
Da un punto di vista puramente sociale un modello P2P favorisce l’inclusione economica, permettendo a chi è escluso dai principali circuiti lavorativi di generare reddito e/o a chi ha bisogno di una risorsa di accedervi a budget limitato; ovviamente anche sul piano ambientale valorizzare prodotti già esistenti permette di ridurre l’impatto umano.
Invece, il modello on-demand della sharing economy permette di accedere a beni o servizi in tempo reale, nel luogo e nel momento del bisogno. Anche in questo caso è la tecnologia a farsi da intermediario tra domanda e offerta, anche se qui il ruolo della piattaforma è centrale e garantisce qualità, sicurezza e stabilità. Un modello davvero interessante, ma che prevede dei limiti che sono insiti nell’essere umano e che possono diventare dannosi se non riconosciuti e “bloccati sul nascere”.
Arriviamo poi alla access economy che è un concetto ombrello che prevede il passaggio dalla proprietà esclusiva al mero utilizzo di un prodotto o servizio. In questo modo non si acquistano i beni, ma se ne usufruisce temporaneamente secondo le proprie necessità e il principale punto di forza del sistema è la possibilità di accedere a beni costosi senza doverli acquistare, ciò permette:
- Riduzione dei costi;
- Valorizzazione di risorse poco usate;
- Maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse.
Da un punto di vista sociale questo modello economico permette di ridurre le barriere di accesso a determinati beni; anche qui la riduzione della necessità di possedere e quindi produrre sempre nuovi oggetti ha un impatto sull’ambiente decisamente positivo.
Stiamo quindi parlando, a ben vedere, di tutti modelli che possono ridefinire il concetto stesso economico-sociale della società e che se gestiti in modo equo possono generare risorse e benessere per tutti (ovviamente stabilendo confini alle dinamiche di potere e alle dinamiche di utilizzo).
Settori coinvolti: mobilità, ospitalità, servizi
L’economia della condivisione è stata dirompente in tantissimi settori, eppure esistono alcuni settori come quello della mobilità, dell’ospitalità e dei servizi in cui la sua influenza è stata profonda ed evidente.
In questi campi l’idea stessa di condivisione e intermediazione digitale ha prodotto cambiamenti significativi nei modelli di consumo, nelle stesse dinamiche di mercato e nelle abitudini quotidiane delle persone. Per esempio il settore della mobilità ha visto affermarsi sistemi di condivisione di:
- Veicoli;
- Spostamenti;
- Parcheggi.
Con il car sharing e il ride sharing il concetto di trasporto ha subito una rivoluzione e ha permesso a tutti di accedere al bene del veicolo solo quando necessario, senza doverne per forza sostenere i costi di proprietà e, in molti casi, ha aiutato chi viaggia a condividere le risorse, ottimizzare le spese e anche ad avere un determinato ritorno economico (nel caso di scambi tra privati).
Ovviamente, la mobilità condivisa si estende a tutti i mezzi come scooter, biciclette, monopattini e quant’altro, soprattutto negli spazi urbani. Anche il settore dell’ospitality ha subito profonde trasformazioni con l’avvento della possibilità di condividere e/o affittare stanze, appartamenti e intere strutture.
Ciò non solo ha reso possibile un mercato più agevole e competitivo, ma ha anche esteso le possibilità a chi vuole viaggiare riducendo i costi, permettendo inoltre ai proprietari di monetizzare spazi inutilizzati.
Oltre alle forme più conosciute, in questo settore, che ammettiamo possano avere anche dei lati oscuri (come la crescita incontrollata di appartamenti e/o stanze in affitto per i soggiorni brevi e turistici a scapito della popolazione) esistono anche esperienze più estese e di vera condivisione come il co-living oppure l’home exchange.
Nel campo di servizi, la sharing economy è presente con una vasta gamma di beni e servizi che vanno dalla prestazione di lavori occasionali o gig economy, alla condivisione di:
- Competenze;
- Spazi;
- Strumenti.
Questo modello ha creato una infinità di servizi personalizzati, flessibili e nuove opportunità di lavoro, ma ha anche, spesso, messo in luce la maggiore precarietà del sistema lavorativo per chi mette in campo le proprie competenze a “lavoro singolo o task”.
La possibilità di accedere a servizi on-demand ha aumentato efficienza e rapidità disponibili per gli utenti, ma ha proposto sfide in termini di qualità delle prestazioni e di tutela dei lavoratori.
Questa panoramica veloce non potrebbe, però essere esaustiva, senza dire che ci sono diversi altri settori influenzati dalla sharing economy come la finanza collaborativa con P2P lending o crowdfunding, l’istruzione, l’alimentazione (food delivery, meal sharing, recupero di cibo non venduto) e persino l’energia.
Vantaggi, limiti e rischi della condivisione
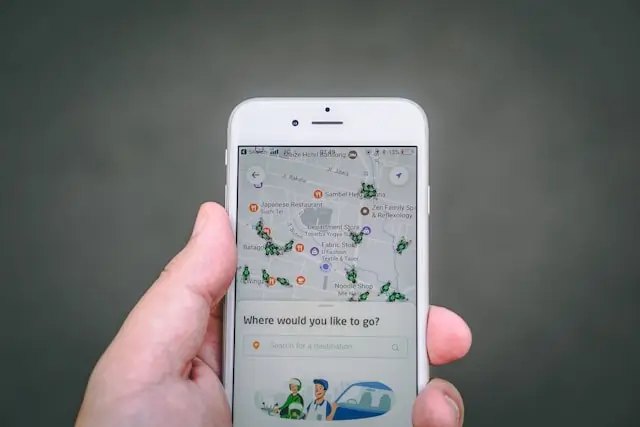
In una economia della condivisione esistono dei vantaggi, ma anche dei rischi potenziali e ovviamente dei limiti da non oltrepassare. Sebbene la sharing economy sia nata dall’esigenza di maggiore efficienza e flessibilità, oggi ha apportato trasformazioni così rilevanti alla società da portare per forza a valutarne pregi e difetti.
Uno degli aspetti più evidenti da mettere in luce è il risparmio economico, la sharing economy abbassa i costi fissi, legati alla proprietà e genera un mercato più ampio e con prezzi inferiori.
Ecco che, questo modello in linea teorica dovrebbe sviluppare una cultura dell’essenziale, in cui si hanno maggiori consapevolezze sulle scelte di spesa e sulle proprie possibilità e dove le risorse sono utili per il collettivo e non solo per il singolo. In questo caso diventa anche possibile scegliere tra diverse opzioni, così da adattare le opzioni alle proprie necessità e non viceversa.
In altra istanza, un secondo aspetto positivo è l’apertura a nuove opportunità di guadagno per chi mette a disposizione beni o servizi e che in alcuni casi può trasformarsi in una vera e propria attività professionale. In questo periodo di crisi economica e incertezza lavorativa, la sharing economy rappresenta una scelta particolarmente attrattiva.
Da un punto di vista di trasformazione poi la sharing economy favorisce anche l’innovazione, con sperimentazione, soluzioni inedite e nuovi modelli di business che nascono. Oltre ai lati positivi della sharing economy non possiamo non mettere in luce anche le ombre del sistema, sarebbe una mancanza di correttezza e darebbe una visione parziale di ciò che sta succedendo ad oggi.
I nuovi modelli di business, in prima istanza, spesso trovano un quadro normativo non evoluto e adatto alle esigenze specifiche, questo rischia di creare tensioni e conflitti rispetto ai settori tradizionali.
Alcuni esempi noti? Airbnb vs strutture alberghiere oppure Uber vs tassisti. In questo caso l’assenza di regole precise elimina anche le tutele del mercato, dei diritti e mina la possibilità di risolvere possibili controversie in modo equo.
Poi, se non ben gestita la sharing economy può, invece che livellare, accentuare le disuguaglianze, spesso l’accesso a piattaforme e opportunità offerte da questo mercato non sono uguali per tutti: chi possiede beni o competenze da condividere spesso ha un vantaggio netto e ciò rischia di rafforzare le disparità esistenti, favorendo chi già ha le risorse e penalizzando chi invece dovrebbe avvantaggiarsi di un’economia di condivisione.
Un esempio concreto di questo è dato dal fenomeno degli affitti brevi che può contribuire, in alcuni casi, alla gentrificazione di quartieri o borghi, all’aumento dei prezzi degli affitti, alla riduzione dell’offerta abitativa per i residenti.
Infine, è doveroso affrontare la precarietà del lavoro: nel mondo della sharing economy e della condivisione delle competenze, spesso si sconfina nella gig economy che viene caratterizzata da incarichi temporanei, spesso con mancanza di garanzie contrattuali, o mancanza di tutele.
Impatto su economia e occupazione
L’impatto che sta avendo la sharing economy sull’economia e sull’occupazione è evidente e meriterebbe una indagine approfondita in altra sede. Da un punto di vista meramente economico i valori di questa economia sono impressionati: circa 570 miliari in Europa nel 2025; uno degli aspetti più interessanti è la distribuzione della ricchezza, che secondo diverse stime porterà circa l’85% dei ricavi ai micro-imprenditori.
Vista sotto l’aspetto dei puri dati parliamo di una economica che porta alla democratizzazione della produzione di valore e a un protagonismo dell’individuo nel dato economico. Questo sistema ha, infatti, abbassato le barriere all’ingresso per chi vuole avviare un’attività di business e per i lavoratori autonomi che vogliono farsi strada nel mercato del lavoro.
Tuttavia, questa apparente democratizzazione ha, invece, criticità rilevanti: ci troviamo di fronte a una ridefinizione dei rapporti di lavoro, alla mancanza di tutele e di stabilità. In molti casi la sharing economy per i singoli micro-imprenditori (che a livello collettivo generano enormi ricavi), vuol dire una nuova forma di precarietà dove la flessibilità diventa insicurezza e mancanza di prospettive sul lungo termine.
Esistono poi, a livello occupazionale, interi settori che vengono messi sotto pressione e ciò ha comportato perdita di posti di lavoro tradizionali. Inoltre, è davvero detto che i benefici economici della distribuzione siano orizzontali? Non è detto: spesso come sempre esistono categorie che partono avvantaggiate e rimangono avvantaggiate e ciò aumenta la concentrazione di potere su poche piattaforme e riduce la possibilità di negoziazioni favorevoli per gli altri.
È vero quindi che da un punto di vista macroeconomico questa è una opportunità, ma i suoi lati positivi potranno divenire dirompenti solo se si scelgono le giuste strade normative e se le persona adottano un tipo di mentalità volta alla continua crescita e alfabetizzazione digitale: una cultura dell’apprendimento costante che aiuterà a non rimanere tagliati fuori da questo nuovo mercato di opportunità.
Regolamentazioni e sfide etiche
Le sfide normative ed etiche di una economia della condivisione sono a dir poco complesse e molteplici. Sul piano normativo la prima criticità è la distinzione tra attività realmente collaborative e modelli di business fumosi che usano questa retorica per aggirare regole e oneri, una ambiguità concettuale di non poco conto.
Un altro punto focale è quello della fiscalità dove le piattaforme generanno flussi di reddito capaci di sfuggire ai sistemi di tassazione tradizionale. In questo la cooperazione tra le piattaforme, spesso internazionali, e le amministrazioni nazionali resta una sfida aperta.
Abbiamo poi già visto i problemi di concorrenza e tutela degli utenti e non è questa la sede per ripetersi. Da un punto di vista etico esistono interrogativi sulla responsabilità sociale delle piattaforme digitali, queste ultime infatti si pongono come semplici intermediari, ma poi di fatto impongono un sistema di controllo significativo.










